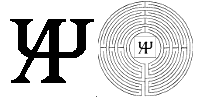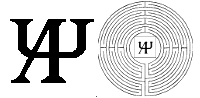SINOSSI “Chi sono i perseguitati in Medio Oriente?”. I palestinesi costretti a emigrare nel sud di Gaza o i
giovani israeliani massacrati e presi in ostaggio dai terroristi di Hamas quando solo pochi secondi
prima ballavano al ritmo della musica elettronica? Gli ebrei della diaspora che sognavano di tornare
in una terra sicura ed essere liberi dai pogrom avvenuti sul suolo europeo, o i palestinesi che,
avendo vissuto per generazioni in quegli stessi luoghi, sono vessati sia dai coloni israeliani sia dai
presunti fratelli arabi che chiudono loro le frontiere? I termini Shoah e Nakba possono essere usati
nella stessa frase? Sono solo alcune delle domande del confronto tra vertici disciplinari diversi
(tragedia greca, filosofia, psicoanalisi) aperte dalla riflessione dello psicoanalista ebreo argentino
Mariano Horenstein. Che afferma che gli psicoanalisti devono stare sempre dalla parte dei
perseguitati. Pensare dalla parte dei perseguitati. Perché se la psicoanalisi merita di continuare ad
esistere, non è solo perché porta un notevole sollievo a chi vi si affida. Non solo perché offre un
insieme di teorie che descrivono il funzionamento psichico dell’essere umano come nessun altro
sapere. Soprattutto perché la psicoanalisi è pensiero critico in una contemporaneità dove prevale il
pensiero unico, omologato e assertivo. Gli autori riflettono, come scrive nell’Introduzione
Francesconi, sulla coazione a ripetersi della Storia, che, confermando Primo Levi, tende a
distruggere ed espellere i perché, il pensiero causale, dando anche morte all’angoscia per liberarsi
dell’angoscia di morte dopo averla depositata illusoriamente nella distruzione di un nostro simile,
solo un po’ dissimile.
Freud a Gaza si propone come particolarmente prezioso non solo per chi si occupa di salute mentale
ma anche per studenti, insegnanti, educatori e per quanti seguono con apprensione questo ‘declino’
dell’umanità nella guerra tra Israele e Hamas.
Le possibilità della psicoanalisi di fronte all’indicibile. Considerazioni a partire da un
libro
Recensione di Davide D’Alessandro
Che cosa può la psicoanalisi di fronte al male, al terrore, all’indicibile? Che cosa può la psicoanalisi
di fronte alla tragedia del 7 ottobre scorso e a ciò che ne è derivato e sembra non avere fine? Che
cosa può la psicoanalisi di fronte al puzzo nauseabondo della morte, di chi cade, bambino o adulto,
donna o uomo, per mano di altri uomini sconsiderati privi di occhi per vedere e di orecchie per
ascoltare?
“Freud a Gaza. Un testimone auricolare: lo psicoanalista”, edito da petite plaisance, a cura di Marco
Francesconi e Daniela Scotto di Fasano, è un libro ma non è soltanto un libro; è una chiamata alla
riflessione profonda, individuale e collettiva, una chiamata che fa riferimento a due termini decisivi,
testimone auricolare, per uno come me nutrito da decenni dall’intelligenza visionaria di Elias
Canetti. Se il testimone auricolare “non affatica la vista, in compenso ha un udito tanto più fine”,
l’analista vive osservando e ascoltando e fa bene Alfredo Lombardozzi nella postfazione a ricordare
una efficace immagine fornita da Roberto Tagliacozzo, secondo il quale l’analista doveva stare “con
un orecchio fuori della stanza di analisi”; perché è fuori che si agitano le cose del mondo, è fuori
che scoppiano le bombe, che si alza il fuoco, che saltano in aria corpi e cose, è fuori che si rende
evidente l’epifania della brutalità degli umani e delle cose stesse, ma è dentro che si riverberano,
che angosciano, che distribuiscono pensieri di morte.
Gli eccellenti contributi di Anna Beltrametti, Silvana Borutti, Alessia Fuusilli De Camillis, Mariano
Horenstein, Lorena Preta e dei già citati Francesconi, Scotto di Fasano e Lombardozzi, aprono alla
possibilità, alla risorsa e, perché no, alla convinzione, più che alla speranza, di una psicoanalisi
costitutivamente strutturata e orientata al pensiero critico, a stare dalla parte dei “perseguitati”,
anche se io prediligo la parola “sofferenti” e ritengo che a Gaza, come in ogni altra parte del mondo,
Freud dovrebbe arrivare prima che quel luogo diventi teatro di morte. Dopo, può essere tardi.
Troppo tardi.
Si chiede Preta: “Portiamo Freud a Gaza come lui a suo tempo pensava di portare in maniera
onnipotente la peste in America? O ci ritroviamo noi stessi tra le rovine di Gaza come degli
increduli, impreparati osservatori o testimoni auricolari e per non soccombere cerchiamo di
tracciare percorsi di pensabilità e di rappresentabilità dell’indicibile?”.
Ma noi siamo a Gaza anche mentre riteniamo di essere altrove. Noi siamo a Gaza anche mentre
guardiamo, comodamente sdraiati sul divano, la nostra imperdibile partita di calcio. Noi siamo a
Gaza perché ci è impossibile essere altrove, oppure riteniamo che la colpa non ci tocchi, non ci
appartenga, essendo sempre di altri, altri diversi da noi, più cattivi, più infami, più disumani?
La psicoanalisi ci insegna che ciò che è nostro è dell’altro, e viceversa. Ascoltando l’altro,
prestando attenzione alla voce e al silenzio dell’altro, ascoltiamo la nostra voce, il nostro silenzio.
Freud a Gaza, e nelle tante altre Gaza che inquietano la terra, è una possibilità di continuare a
coltivare l’indignazione, se ne è rimasta, e a credere nella cura, intesa come trasformazione,
cambiamento.
È necessario, urgente, sapere chi siamo e di che cosa siamo capaci. Se non riusciamo a mutare il
corso degli eventi, se Gaza è inesorabilmente e ripetutamente davanti ai nostri occhi, vuol dire che
siamo ancora lontani, molto lontani, dal comprendere chi siamo e di che cosa siamo capaci.
Tutti, non soltanto e sempre gli altri.