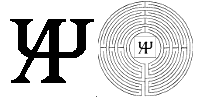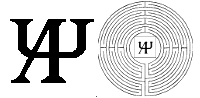Relazione presentata al 1° Congresso del Centro Psicoanalitico di Pavia “Narrazioni psicoanalitiche delle crisi: descrizione, racconto, risoluzione”, Pavia, 9 marzo 2013
C’era una volta … l’isteria
Le prime crisi che la psicoanalisi ha incontrato, e in rapporto alle quali si è costituita come specifica forma di cura e di conoscenza, sono le crisi isteriche.
Una novità dell’approccio psicoanalitico all’isteria, forma morbosa che metteva in scacco i paradigmi neurologici e psichiatrici dell’epoca, si può individuare nell’impiego di una prospettiva narratologica ante litteram. I sintomi isterici, che la semeiotica medica riconduceva a modelli impersonali di funzionamento organico, vengono considerati come espressione di intime vicissitudini della storia personale dei pazienti: vicissitudini inconsce, che si tratta di rendere accessibili alla coscienza per poterli integrare in una adeguata narrazione.
La nota formula freudiana “l’isterica soffre di reminiscenze” sintetizza questa concezione dei sintomi come equivalenti, a livello di espressività corporea, di ricordi mancanti nel racconto della propria vita che il paziente fornisce al terapeuta: racconto che risulta, perciò, lacunoso e disarmonico nella sua articolazione.
In tale prospettiva (qui, ovviamente, molto schematizzata) la situazione analitica è il luogo dove il terapeuta, grazie a una apposita tecnica dialogica e interpretativa basata sulle libere associazioni, aiuta il paziente a recuperare i ricordi rimossi. Diventano così raccontabili esperienze emotive traumatiche e conflittuali, la cui natura afferisce a quella psicosessualità infantile scoperta e studiata dalla psicoanalisi come contenuto peculiare dell’inconscio.
L’enfasi sull’efficacia del “rendere conscio l’inconscio” non impediva, già per Freud, di considerare come altro fattore terapeutico l’atteggiamento di tolleranza e benevola neutralità dell’analista verso moti pulsionali e desideri che il paziente poteva così sperimentare in un contesto relazionale più accogliente di quello originario, attenuandosi in tal modo l’intensità degli antichi conflitti.
Questo paradigma teorico e tecnico della neonata psicoanalisi andò incontro a una profonda crisi − i cui effetti trasformativi non sono ancor oggi esauriti − in occasione del trattamento di una giovane paziente, chiamata Dora. Il caso è diventato celebre come la prima esperienza analitica descritta da Freud in modo dettagliato, producendo un testo che, con sua stessa sorpresa, risultò più simile a un racconto che a un tradizionale resoconto clinico.
Scelto da Cesare Segre (1984) per un magistrale studio narratologico dello stile espositivo di Freud, il caso di Dora rappresenta anche per il lettore psicoanalista un testo esemplare, che mostra già nella forma il travaglio di ripensamenti a cui l’autore lo ha sottoposto nei diversi tempi della sua composizione.
L’analisi della diciottenne inviata a Freud dal padre per disturbi isterici, iniziata nell’autunno del 1900 e interrotta dalla paziente dopo soli tre mesi, anche all’epoca risultava troppo breve e incompleta per costituire un modello di trattamento da presentare alla comunità scientifica. Ma Freud ne fu in un primo tempo abbastanza soddisfatto, perché la considerava una buona conferma clinica delle sue ipotesi riguardo la natura dell’isteria e, più specificamente, il posto che l’interpretazione dei sogni poteva avere nella cura, come egli era allora molto interessato a dimostrare. A ciò si aggiunga l’impressione − registrata da Freud nella prima stesura del lavoro − che gli effetti terapeutici, benché parziali, fossero stati abbastanza utili per consentire alla paziente un deciso miglioramento della sua vita, testimoniato anche dalla notizia (rivelatasi poi non vera) di un felice matrimonio.
I motivi di insoddisfazione e di ripensamento emersero via via nei quasi cinque anni trascorsi dal primo resoconto della storia clinica alla pubblicazione dell’articolo. Se ancor oggi li possiamo cogliere con particolare vividezza è grazie alla scelta stilistica operata da Freud che, invece di riscriverlo, mantenne invariato il testo originario, integrandolo con note a piè di pagina (alcune delle quali aggiunte anche dopo la prima pubblicazione) e con un corposo poscritto.
Il principale motivo di cruccio, insieme clinico e teorico, per il Freud supervisore di se stesso al lavoro con Dora, consiste nella sua incapacità a riconoscere tempestivamente il transfert per poterlo interpretare e utilizzare ai fini della cura.
Al tempo dell’analisi di Dora Freud aveva già formulato il concetto di transfert, ma non lo considerava ancora un elemento essenziale del processo terapeutico. Per transfert egli intendeva, fino ad allora, un “falso nesso” associativo, tale per cui la carica pulsionale di una rappresentazione inconscia rimossa viene spostata su un’altra rappresentazione più “innocente” e perciò accessibile al preconscio (Barale, 1993). Il trasferimento sulla persona del medico di desideri e timori originariamente vissuti in rapporto a figure significative dell’infanzia sarebbe, in questa ottica, un caso particolare di falso nesso.
Ma il transfert che l’analista Freud sperimenta con Dora, scoprendolo drammaticamente solo nel poscritto, è qualcosa di nuovo e ben diverso.
“L’interpretazione dei sogni, l’estrazione dei pensieri e dei ricordi inconsci dalle associazioni del malato” erano, in fondo, “procedimenti di traduzione”, che un buon analista poteva apprendere con relativa facilità nella sua preparazione tecnica; “in essi lo stesso paziente fornisce sempre il testo. Il transfert, invece, dev’essere intuito dal medico senza l’aiuto del malato, sulla base di piccoli indizi e guardandosi dai giudizi arbitrari”. (Freud, 1901, 397). Poiché, come è avvenuto nel caso di Dora, il paziente “mette in atto una parte essenziale dei suoi ricordi e delle sue fantasie, invece di riprodurla nella cura” (ibid., 399, corsivo originale).
“In altri termini […] esperienze psichiche precedenti riprendono vita, non però come stato passato, ma come relazione attuale con la persona del medico”. E ciò può avvenire “appoggiandosi su una qualche particolarità reale, abilmente utilizzata, della persona del medico o del suo ambiente” (ibid., 397).
Concentrato, per sua stessa ammissione, nell’interpretare il materiale portato da Dora, inclusi i sogni, nel senso indicatogli dalle sue ipotesi patogenetiche, Freud non si accorse in tempo che quello che si stava riproducendo nella cura non era un conflitto interno di Dora suscitato dal suo desiderio edipico verso il padre e verso gli uomini che lo rappresentavano transferalmente (il signor K., lo stesso Freud), bensì il rapporto conflittuale con un genitore – forse dai tratti più materni che paterni − vissuto da Dora come non autenticamente affezionato e interessato a lei bambina, perché troppo occupato dai suoi interessi nel mondo degli adulti (Lopez, 1967; Regazzoni Goretti, 2006).
E’ noto che nei successivi sviluppi del pensiero freudiano il transfert, presentatosi nel caso di Dora come “il più grave ostacolo per la psicoanalisi”, ne diventa “il miglior alleato”, in quanto rende “l’inestimabile servizio” di attualizzare sul terreno della relazione analitica quei conflitti infantili patogeni sepolti nell’inconscio e altrimenti inaccessibili, consentendo al paziente e all’analista di sperimentarli e trattarli a caldo, dal vivo. Ne consegue una nuova visione del processo terapeutico in psicoanalisi, che ha nel concetto freudiano di “nevrosi di transfert” un elemento centrale: solo assumendo la forma di fenomeni transferali la malattia del paziente può diventare oggetto di cura. Si afferma il principio che “nessuno può essere battuto in absentia o in effigie” (Freud, 1912a, 531, corsivi originali).
Tuttavia, anche dopo questa svolta teorica e tecnica Freud non cessò di far notare la delicatezza e l’impegno del compito con cui l’analista deve cimentarsi quando si manifestano in seduta gli effetti emotivi più intensi del transfert. Il lieto fine della guarigione non è affatto garantito e talvolta la riaccensione di turbolenti moti dell’animo può mettere a repentaglio la tenuta della relazione analitica.
Il caso di Dora rappresenta un monito della drammatica sfasatura che può verificarsi, anche per il miglior analista, tra l’esperienza del transfert e il suo riconoscimento come premessa dell’elaborazione terapeutica. Il fattore essenziale da cui dipende questo differimento della consapevolezza è riconducibile a un concetto che, affacciatosi appena nell’opera di Freud, anche nella psicoanalisi postfreudiana ha trovato tardi e a fatica il posto che gli spettava: il controtransfert.
Rileggendo oggi il caso di Dora appare con molta evidenza qualcosa che solo in tempi successivi è diventato visibile nella comunità analitica senza creare troppo imbarazzo per la rispettabilità scientifica e clinica della psicoanalisi. Cioè, il fatto che Freud con Dora mise in atto inconsciamente proprio quel ruolo genitoriale patogeno che la paziente gli attribuiva nel transfert.
L’inquietante asserzione freudiana che, dopo la scoperta dell’inconscio, “l’Io non è padrone in casa propria” (Freud, 1916, 663, corsivo originale) va dunque integrata con un corollario non del tutto previsto (pur essendo logicamente, oltre che eticamente, ineccepibile), che si potrebbe formulare così: l’analista non è padrone nella stanza di analisi.
Cent’ anni dopo
Facendo fare al mio discorso un salto temporale, tratterò ora alcuni aspetti del pensiero psicoanalitico odierno guardandoli come tentativi di elaborazione della crisi aperta dal caso di Dora, oltre che come contributi allo sviluppo di una disciplina che abbiamo ereditato da Freud in uno stato di vitale incompletezza.
Un problema di ardua soluzione e tuttora fonte di controversie è quello di integrare nella teoria e nella tecnica della talking cure analitica quella dimensione di messa in atto che aveva portato all’interruzione dell’analisi di Dora.
La riflessione postfreudiana si è fermata a lungo sull’antitesi parlare/agire. In questa coppia di opposti l’azione era considerata una minaccia alla comunicazione analitica. Se poteva essere accettabile nel paziente, purché in misura contenuta, come espressione della sua patologia, lo era assai meno nell’analista, la cui presenza in seduta doveva coincidere idealmente con una funzione ermeneutica esercitata sul testo prodotto dal paziente per svelarne i significati inconsci.
Nonostante il richiamo di Lacan (1953) alla natura della parola come “corpo sottile”, ma sempre corpo − espressione che riecheggia quella classica di Gorgia (1) − le idee sul linguaggio a cui gli psicoanalisti, compreso lo stesso Lacan, generalmente si riferivano erano mutuate dalla linguistica strutturale saussuriana, incentrata sul rapporto significante/significato e sullo studio della lingua come sistema di segni.
Solo in epoca abbastanza recente la psicoanalisi ha potuto avvalersi delle ricerche di filosofi e linguisti orientati a vedere il linguaggio innanzi tutto come mezzo di comunicazione tra esseri umani, sottolineandone la dimensione pragmatica rispetto a quella semantica e sintattica.
A questo proposito voglio citare tre studiosi pavesi il cui pensiero, nel corso degli anni, è stato per me − e certamente non solo per me − molto fecondo in tal senso, grazie all’opportunità di avere con loro, in momenti diversi, uno scambio di idee dal vivo. Si tratta di Silvana Borutti (2), Claudia Caffi (3), Michele Prandi (4).
Nel nuovo panorama degli studi sul linguaggio, la consapevolezza che con le parole si possono fare molte cose influenza positivamente anche l’indagine sull’esperienza specifica della stanza di analisi dove, secondo la lapidaria (e un po’ ironica) espressione freudiana, “fra paziente e analista non accade nulla, se non che parlano fra loro” (Freud, 1926, 355).
La presenza dell’analista come persona e la sua partecipazione all’incontro con il paziente in modi non certo riducibili a una pura funzione ermeneutica sono oggi generalmente riconosciute e accettate nella comunità analitica senza troppe difficoltà.
Quella che, pur essendo innegabile, continua a suscitare problemi teorici e tecnici mai del tutto risolti è la componente inconscia di tale partecipazione.
Con la nota metafora del telefono (5) Freud assegna all’inconscio dell’analista una parte essenziale del lavoro terapeutico: ricevere ciò che proviene dall’inconscio del paziente e trasformarlo in messaggi coscienti. Pur non avendo sviluppato nella sua opera questo importante assunto, egli ipotizza quale dotazione naturale della psiche umana una forma di “intelligenza inconscia” in grado di cogliere le espressioni emotive dell’inconscio altrui anche senza averne consapevolezza.
Ci lascia oggi un po’ perplessi il fatto che, nell’uso freudiano della metafora, il telefono dell’analista venga considerato un apparecchio solo ricevente e non, come sarebbe logico aspettarsi, anche trasmittente. Questa restrizione va, probabilmente, ricondotta alle preoccupazioni di Freud per il controtransfert, impostosi alla sua attenzione in quegli stessi anni quale disturbo prodotto nel terapeuta da sue problematiche inconsce non risolte, che possono dar luogo in seduta a distorsioni percettive, macchie cieche e reazioni emotive incontrollate.
Questa duplice e contraddittoria potenzialità attribuita all’inconscio dell’analista (strumento di lavoro ma anche fonte di possibili interferenze) rende ragione della difficoltà, protrattasi a lungo anche dopo Freud, ad ammettere come inevitabile, anche per l’analista meglio preparato e più esperto, una certa quota di interazione con il paziente che, proprio perché inconscia, non può essere subito riconosciuta e padroneggiata.
Ciò implica per l’analista la predisposizione a trovarsi coinvolto in dinamiche relazionali di cui diverrà consapevole, se tutto va bene, solo a distanza di tempo e dopo un’adeguata elaborazione. Questa condizione di “non sapere ancora” (Bollas, 1987), che richiede l’esercizio della “capacità negativa” di cui parla Bion, riguarda non solo ciò che il paziente prova e pensa, ma anche chi noi siamo per lui in un certo momento, quale ruolo stiamo inconsciamente personificando. Persino l’interpretazione che consideriamo, al momento di enunciarla, la più corretta e puntuale, potrà successivamente rivelarsi uno dei modi in cui abbiamo piuttosto “interpretato” − cioè messo in atto − un ruolo.
Il termine tedesco agieren, con cui Freud designa la messa in atto del transfert, ha già nel suo alone semantico una connotazione teatrale. Altrettanto si può dire per il suo equivalente inglese acting out, che tuttavia è stato a lungo usato in psicoanalisi più nella accezione negativa di agito-scarica, contrapposto al pensiero e alla simbolizzazione. Il più recente termine angloamericano enactment (Filippini e Ponsi, 1993) valorizza invece, in un mutato contesto teorico-clinico, la dimensione potenzialmente espressiva del fenomeno e, nello stesso tempo, la sua matrice relazionale, che coinvolge sia il paziente sia l’analista.
La metafora teatrale, come ha ben evidenziato Fausto Petrella (2010), svolge una funzione importante nella costruzione della teoria psicoanalitica e serve, tra l’altro, a compensare un modello dell’esperienza clinica altrimenti a rischio di appiattirsi troppo sul testo dello scambio verbale.
Riconoscere che la messa in atto nella situazione analitica può costituire un passaggio verso la pensabilità e la narrazione cosciente non significa, comunque, dare per scontato né automatico un simile sviluppo, che è invece la meta di uno specifico e talvolta arduo lavoro terapeutico. Questo lavoro di rappresentazione e trasformazione è sempre esposto al rischio che Freud (1914) segnalava nel suo saggio sull’amore di transfert, cioè di doversi interrompere per il pericolo di incendio nel teatro, provocato da cortocircuiti di natura non soltanto amorosa. D’altronde, è per l’analista una componente essenziale della sua funzione quella di lasciarsi coinvolgere, entro i limiti del setting, in dinamiche emotive ancora ignote e impensabili, perché solo attualizzandosi sulla scena analitica come esperienza condivisa il dramma personale del paziente può essere compreso e riaperto a nuovi sbocchi.
De nobis fabula narratur
Date queste premesse, non è sorprendente che Bion guardi alla seduta analitica come a un incontro tra due persone spaventate, entrambe esposte all’incertezza e alla turbolenza di emozioni ancora senza nome che si attivano tra loro.
E’ proprio collegandosi a questa prospettiva che Dario De Martis (1982) ricorre al concetto di crisiper definire una caratteristica immanente della situazione analitica. Con il suo stile personale, ben noto a chi lavorava con lui, De Martis si mostra all’unisono con Bion nel fornirci una visione dell’analisi e dell’analista scevra da edulcorazioni e da facili trionfalismi.
Nessun bagaglio teorico, nessuna raffinatezza tecnica possono evitare all’analista di trovarsi cimentato nell’avventura emotiva e cognitiva di quelle fasi critiche di impasse o di burrascosa instabilità che caratterizzano i passaggi decisivi dell’analisi, specialmente − ma non solamente − con i pazienti cosiddetti “gravi”.
Utilizzando il concetto bioniano di cambiamento catastrofico, De Martis sottolinea che solo attraversando questi frangenti si può aprire la via a un processo di autentica trasformazione e crescita psichica. In ciò le sue idee sono in sintonia anche con quelle di un altro grande psichiatra e psicoanalista, quasi suo coetaneo e scomparso nello stesso anno (1996), cioè P.-C. Racamier, il quale nei suoi lavori parla di crisi necessaria, nella cura analitica così come nel percorso vitale degli esseri umani.
Una linea di pensiero convergente con quella di Bion, scaturita dal pieno riconoscimento del fatto che in analisi si incontrano due soggetti con le rispettive componenti inconsce della personalità, porta W. e M. Baranger a formulare un modello teorico-clinico che configura la situazione analitica come campo bipersonale. Ciò implica, tra l’altro, che la fantasia inconscia messa in atto nella seduta non va più intesa come appartenente solo al mondo interno del paziente, ma come una nuova entità creata dai due membri della coppia (analogamente a quanto accade nei gruppi).
In quest’ottica il concetto freudiano di nevrosi di transfert viene riformulato valorizzandone appieno la centralità nel processo della cura (Bezoari, 2002). Riconoscendo il suo inevitabile versante controtransferale, la forma di relazione patologica in cui il paziente coinvolge l’analista è a sua volta intesa come un prodotto della coppia e costituisce quella malattia del campo bipersonale che sarà l’oggetto specifico dell’elaborazione terapeutica. Soltanto così la malattia di cui soffre il paziente può entrare nella situazione analitica diventando esperienza condivisa.
I Baranger chiamano “bastione” questo tipo di neoformazione inconscia che tende a bloccare il libero flusso dei pensieri e delle emozioni tra paziente e analista, determinando una crisi del precedente assetto di lavoro della coppia analitica. Mi soffermerò più avanti sulle risorse a cui analista e paziente possono attingere per superare questo genere di crisi. Qui vorrei sottolineare che lo scioglimento emotivo e cognitivo di ciò che prima era inconsciamente agito nel bastione è un evento che modifica l’assetto del campo, dando luogo a nuove configurazioni relazionali che, a loro volta, potranno generare nuovi bastioni.
La situazione analitica è quindi predisposta a essere la sede di quelle crisi che il paziente ha bisogno di attraversare insieme all’analista per poter risolvere i blocchi patogeni che producono sofferenza e condizionano la sua vita psichica.
Nell’ottica di campo anche l’elaborazione terapeutica delle crisi è concepita come una funzione della coppia e non del solo analista.
Quando Bion dice che “il paziente è il miglior collega” allude a qualcosa di più del tradizionale concetto di alleanza terapeutica. Se può essere tollerabile un certo grado di collusione inconscia tra paziente e analista nel mettere in atto le forme relazionali patogene, è perché esiste tra loro anche una cooperazione inconscia tesa a rendere pensabile e raccontabile quanto viene agito a livello emotivo profondo. Anche all’inconscio del paziente vanno riconosciute le capacità di percezione dell’esperienza vissuta nell’incontro con l’altro che Freud valorizzava nell’analista con la metafora del telefono, considerandole tuttavia ubiquitarie negli esseri umani.
Alla base di tali competenze c’è quella che Bion ha chiamato funzione alfa, cioè un tipo basilare di lavoro onirico, sempre attivo anche nella veglia, che trasforma le emozioni in elementi protosimbolici (gli elementi alfa) utilizzabili per sognare e per pensare.
L’ascolto dell’analista sarà dunque aperto a cogliere nelle comunicazioni del paziente non solo gli indizi sintomatici del transfert, ma anche i segnali dell’esperienza emotiva in corso tra loro.
Così come per il racconto dei sogni notturni, tutte le espressioni verbali di questa attività onirica diurna hanno una dimensione intrinsecamente narrativa, quale che sia il genere del discorso manifesto (ricordo, descrizione, riflessione, ecc.). Esse condividono, infatti, la natura di narrazione originaria (Ferrari e Garroni, 1987): quella dei miti, quella che dà forma al mondo, come accade tipicamente nell’infanzia e come può accadere anche nella vita adulta ogni volta che un’emozione prima solo sofferta e inconsciamente agita viene simbolizzata e resa comunicabile all’interno di una relazione intersoggettiva.
Narrativa si può anche chiamare, in un’accezione più estesa, la proprietà del dialogo analitico che consente, oltre alla comunicazione di significati, un transito di affetti tra i parlanti, così che il nuovo senso emergente è il frutto di un sentire insieme.
Quando emergono nel dialogo tra paziente e analista rappresentazioni che si rivelano efficaci a simbolizzare l’esperienza emotiva in atto nella coppia e fino ad allora non riconosciuta, l’origine di tali rappresentazioni non è facilmente riconducibile all’uno o all’altro come individui separati.
Una ventina d’anni or sono, con Antonino Ferro abbiamo definito aggregati funzionali questi elementi che si generano nel campo analitico. “Aggregati” per significarne la natura composita, frutto della cooperazione − inconscia e preconscia prima che conscia − tra paziente e analista; “funzionali” in quanto idonei a rappresentare ciò che sta avvenendo tra loro a livello di scambi emotivi profondi. Abbiamo anche paragonato ad ologrammi queste figure virtuali prodotte dalla convergenza di due fonti di visione onirica, che si animano nello spazio intersoggettivo della seduta dando forma ai personaggi necessari per lo sviluppo del racconto analitico (Bezoari e Ferro, 1991; Ferro, 2009).
Noto, per inciso, che in questa prospettiva le differenze teoriche e tecniche fra i concetti di interpretazione, costruzione, narrazione si attenuano fino a risolversi nel concetto più generale, utilizzato da Bion (1965), di trasformazione.
Parafrasando Francesco Corrao (che fu tra i primi a introdurre in Italia il pensiero di Bion e che ha proposto un’originale versione del modello di campo), analista e paziente sono quindi “coautori della produzione narrativa in analisi”, così come sono “coattori nei momenti drammatici” delle crisi che possono attraversare (1987, 62). Va detto che la responsabilità dell’analista non è perciò diminuita, restando egli il garante del buon funzionamento dell’intero dispositivo analitico a beneficio del paziente.
Anche il polo ermeneutico dell’interpretazione non è disgiunto da una componente narrativa, a prescindere dalla forma della sua enunciazione. Per essere assimilata dal paziente e produrre effetti mutativi l’interpretazione analitica non può, infatti, limitarsi a svelare contenuti psichici prima inaccessibili alla coscienza, ma deve recare in sé le tracce delle specifiche vicissitudini condivise da quel paziente e da quell’analista per giungere alla pensabilità di quei contenuti. Anche quando tende a configurare aspetti del mondo interno del paziente, il principale criterio di verità dell’interpretazione analitica (Gaburri, 1987) sta nella sua corrispondenza a ciò che viene coesperito nell’incontro tra le due menti, piuttosto che ad altri livelli di realtà storica o fattuale.
Pur nascendo nell’hic et nunc della seduta, il racconto analitico non è mai “in diretta”, ma sempre “in differita”. La sua specifica dimensione temporale è la freudiana Nachträglichkeit, l’après-coupdei francesi, che stabilisce la posteriorità del senso rispetto all’evento. Ciò comporta l’inevitabile ritardo (talora breve, spesso abbastanza lungo) con cui analista e paziente possono avere consapevolezza di quanto sta accadendo inconsciamente nel loro incontro.
Paragonando la realtà psichica a un universo in continua espansione, Bion dice che l’analista deve prepararsi a tollerare che, anche quando giunge con il paziente alla migliore delle interpretazioni possibili, “appena egli ha finito di parlare l’universo si è già espanso al di là della sua vista” (1973, 121).
Il tempo psichico del racconto nella situazione analitica è, dunque, un tempo imperfetto, così come la sua struttura narrativa è sempre incompiuta. Ma questi limiti sono anche funzionali alle finalità terapeutiche dell’analisi.
Giuseppe Di Chiara (1992) identifica tre fattori fondamentali dell’esperienza analitica designandoli come “l’incontro, il racconto, il commiato”. Poiché mi sembra che quanto ho esposto fin qui si possa collegare ai primi due fattori, vorrei soffermarmi brevemente sul terzo.
Il commiato non è solo riferibile alla fase finale dell’analisi, ma corrisponde a una qualità di separatezza che l’analista deve garantire fin dall’inizio, anche nei momenti di massima intimità dell’incontro, per salvaguardare e far sviluppare il senso di irriducibile soggettività del paziente nel rapporto con l’altro da sé e con l’altro dentro di sé.
E’ auspicabile che il paziente, dopo avere soggiornato per il tempo necessario nella “intima stanza” dell’analisi (come poeticamente l’ha definita Giuseppe Civitarese), se ne allontani sentendosi il più possibile libero ed emancipato anche rispetto al legame di dipendenza dall’analista.
L’incompiutezza del racconto analitico non è dunque un difetto, perché lascia aperto uno spazio virtuale in cui il paziente potrà mettere a frutto le sue competenze mitopoietiche arricchite nel corso dell’analisi, diventando a pieno titolo autore e narratore in prima persona della propria autobiografia emotiva come work in progress, il cui finale coinciderà con il limite dell’esistenza.
NOTE
(1) “[…] la parola è un gran dominatore, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo, divinissime cose sa compiere; riesce infatti e a calmar la paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia, e ad aumentar la pietà.”
Gorgia, Encomio di Elena, trad. di M. Timpanaro Cardini. In I presocratici, Bari, Laterza, 1990, 929-930.
(2) In un libro sul significato, pubblicato nel 1983, S. Borutti esponeva una prospettiva filosofica di ampio respiro sugli “atti di discorso” nel contesto dei rapporti intersoggettivi. La lettura di questo libro mi fu di grande utilità per impostare, alcuni anni dopo, un lavoro di riflessione teorico-clinica sulle modalità di costruzione del senso nell’incontro analitico (Bezoari e Ferro, 1990).
(3) C. Caffi porta avanti da tempo una ricerca orientata a includere nell’approccio pragmatico gli aspetti psicologici dell’interazione verbale, con particolare riguardo alle componenti emotive. Dedicando uno specifico interesse alle relazioni terapeutiche, il suo percorso ha suggestive intersezioni con la psicoanalisi, come risulta chiaro dal concetto organizzatore del suo libro sulla mitigazione (2000), che la stessa autrice collega, tra l’altro, con il tema psicoanalitico della modulazione interpretativa (trattato, ad esempio, da Meltzer in un noto scritto su temperatura e distanza come dimensioni tecniche dell’interpretazione).
(4) Di M. Prandi ricordo, in particolare, un bell’articolo (di cui ho introdotto la pubblicazione sulla rivista Psiche, 1996) centrato sull’idea che il significato dell’espressione linguistica funge nella comunicazione come indice di un messaggio che può essere correttamente interpretato dal destinatario solo riferendolo alla situazione condivisa dagli interlocutori.
(5) “[Il medico] deve rivolgere il proprio inconscio come un organo ricevente verso l’inconscio del malato che trasmette; deve disporsi rispetto all’analizzato come il ricevitore del telefono rispetto al microfono trasmittente. Come il ricevitore trasforma in onde sonore le oscillazioni elettriche della linea telefonica che erano state prodotte da onde sonore, così l’inconscio del medico è capace di ristabilire a partire dai derivati dell’inconscio che gli sono comunicati, questo stesso inconscio che ha determinato le associazioni del malato.” (Freud ,1912b, 536-537).
BIBLIOGRAFIA
Barale F. (1993). Transfert: dalle origini al caso di Dora. Riv.Psicoanal., 39, 481-498.
Baranger M., Baranger W. (1961-1962). La situazione analitica come campo dinamico. In Baranger W. e M., La situazione analitica come campo bipersonale. Milano, Cortina, 1990.
Bezoari M. (2002). La nevrosi di transfert come funzione del campo analitico. Riv.Psicoanal., 48, 889-905.
Bezoari M., Ferro A. (1990). Parole, immagini, affetti. L’avventura del senso nell’incontro analitico. In G. Bartoli (a cura di) In due dietro al lettino. Scritti in onore di Luciana Nissim Momigliano.Castrovillari, Teda Edizioni.
Bezoari M., Ferro A. (1991). Percorsi nel campo bipersonale dell’analisi: dal gioco delle parti alle trasformazioni di coppia. In L. Nissim Momigliano e A. Robutti (a cura di), L’esperienza condivisa. Milano, Cortina, 1992.
Bion W.R. (1965). Trasformazioni. Roma, Armando, 1973.
Bion W.R. (1973). Seminari brasiliani. In Il cambiamento catastrofico, Torino, Loescher, 1981.
Bollas C. (1987). L’ombra dell’oggetto. Roma, Borla, 1989.
Borutti S. (1983). Significato. Saggio sulla semantica filosofica del ‘900. Bologna, Zanichelli.
Caffi C. (2000). La mitigazione. Un approccio pragmatico alla comunicazione nei contesti terapeutici. Pavia, Cooperativa Libraria Universitaria.
Civitarese G. (2008). L’ntima stanza. Teoria e tecnica del campo analitico. Roma, Borla.
Corrao F. (1987). Il narrativo come categoria psicoanalitica. In Orme, vol.1, Milano, Cortina, 1998.
De Martis D. (1982). La psicoanalisi come situazione di crisi. In Realtà e fantasma nella relazione terapeutica. Saggi psicoanalitici. Roma, Il Pensiero Scientifico, 1984.
Di Chiara G. (1992). L’incontro, il racconto, il commiato. Tre fattori fondamentali dell’esperienza psicoanalitica. In L. Nissim Momigliano e A. Robutti (a cura di) L’esperienza condivisa. Milano, Cortina.
Ferrari A., Garroni E. (1987). La narrazione originaria. La temporalità nella relazione analitica e nel racconto. In E. Morpurgo, V. Egidi (a cura di) Psicoanalisi e narrazione. Ancona, Il Lavoro Editoriale.
Ferro A. (2009). Trasformazioni in sogno e personaggi del campo psicoanalitico. Riv.Psicoanal., 55, 395-420.
Filippini S., Ponsi M. (1993). “Enactment”. Riv.Psicoanal., 39, 501-516.
Freud S. (1901). Frammento di un’analisi d’isteria (Caso clinico di Dora). O.S.F., 4.
Freud S. (1912a). Dinamica della traslazione. In Tecnica della psicoanalisi. O.S.F., 6.
Freud S. (1912b). Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico. In Tecnica della psicoanalisi. O.S.F., 6.
Freud S. (1914). Osservazioni sull’amore di traslazione. In Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi. O.S.F., 7.
Freud S. (1916). Una difficoltà della psiconanalisi. O.S.F., 8.
Freud S. (1926). Il problema dell’analisi condotta da non medici. Conversazione con un interlocutore imparziale. O.S.F., 10.
Gaburri E. (1987). Narrazione e interpretazione. In E. Morpurgo, V. Egidi (a cura di) Psicoanalisi e narrazione. Ancona, Il Lavoro Editoriale.
Lacan J. (1953). Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi. In Scritti, vol. I . Torino, Einaudi, 1974.
Lopez D. (1967). Rileggendo Freud: il caso Dora. Riv.Psicoanal., 13, 215-262.
Petrella F. (2010). La mente come teatro. Psicoanalisi, mito, rappresentazione. Milano, Centro Scientifico Editore.
Prandi M. (1996). “E’ mezzogiorno”. Il significato delle espressioni e l’interpretazione dei messaggi. Psiche, IV, 1, 49-63.
Racamier P.-C., Taccani S. (2010). La crisi necessaria. Il lavoro incerto. Milano, Franco Angeli.
Regazzoni Goretti G. (2006). Una florida ragazza dai lineamenti intelligenti e attraenti. Riv.Psicoanal., 52, 969-990.
Segre C. (1984). Il caso di Dora: anamnesi e romanzo. In Teatro e romanzo. Torino, Einaudi.